Speciale Torino Film Lab

La scuola Holden si trova in un antico edificio industriale di mattoncini rossi sulle rive della Dora a Torino. Il palazzo, con il suo bel cortile, da subito evoca più i college anglosassoni che le nostre università e fa piacere vedere nobilitata dalla bellezza la nostra professione, spesso ancora così poco considerata. Aspettandomi di vedere il professor Keating, incontro invece Savina Neirotti, fra le fondatrici della Holden, che è la mente che ha creato il Torino Film Lab, il programma europeo di formazione e sviluppo per i giovani autori cinematografici e non solo.
Savina, di solito iniziamo le interviste agli sceneggiatori chiedendo un pitch del film, mi faresti un pitch del Torino Film Lab?
Il Torino film lab nasce 8 anni fa, quest’anno siamo alla nona edizione. L’idea di base è unire tre ingredienti: la formazione, lo sviluppo e il sostegno alla produzione, tre aspetti che normalmente non si trovano in uno stesso luogo. In Europa ci sono istituzioni che si occupano di formazione, ci sono mercati di co-produzione molto belli e ci sono fondi. Ma non c’era una cosa che unisse questi tre momenti sotto un unico cappello, che fosse dedicato ai registi e agli sceneggiatori e ai produttori di opere prime e seconde, e che avesse una vocazione internazionale da subito, aperto a progetti da tutto il mondo. Noi siamo partiti dicendo che ci occuperemo di formazione, però ci occuperemo anche di far si che questi progetti incontrino la produzione e alcuni li sosteniamo anche finanziariamente. Quindi seguiamo l’intero ciclo del film.
Come funziona il lavoro del Lab?
Sviluppiamo i progetti in modo molto particolare, perché è tutto basato sul lavoro di gruppo. Quindi ognuno arriva con la propria idea, ma il suo lavoro è indispensabile anche sui progetti altrui. Quindi c’è questo scambio, tra persone di culture, paesi ed esperienze diversi, che si trovano a condividere un lavoro comune, guidati da professionisti story editor, che conoscono il funzionamento delle storie, ma sono in grado di seguire ciascun progetto per la sua voce individuale. Guardando i film usciti dal Torino Film Lab si vede che non ce n’è uno uguale all’altro. Non c’è l’intenzione di imporre una visione, un metodo, come se i film si facessero in un certo modo; ma c’è un’attenzione specifica a ciascuno e soprattutto un’energia di scambio e dialogo che permette al film di avere sia un aspetto molto locale e unico e di rispettare la voce del regista. In realtà con questo lavoro di sviluppo si riesce anche a capire quali potrebbero essere gli ostacoli che impediscono al tuo film di essere universale, quindi è come un modo di co-produrre a livello di idee.
Questo del lavoro collettivo è un approccio interessante, soprattutto da noi dove un certo cinema sembra avere ancora il mito dell’autore solitario.
Certo, sono dei momenti di full immersion in cui sono in 20 sceneggiatori, anche se poi lavorano in gruppi di quattro. La scrittura è fatta anche di momenti di scambio. Abbiamo in molti casi due sceneggiatori già su un progetto, c’è sempre più spesso il co-sceneggiatore. Per noi l’aspetto collettivo, di scambio e di mettersi in gioco è fondamentale. Questo succede da noi ed è abbastanza diverso dal pregiudizio che si ha sull’Italia… bisogna mettersi molto in discussione. La visione dei progetti viene veramente analizzata e messa sotto scrutinio, in inglese mi verrebbe da dire challenged, testata, ma in una maniera costruttiva. Bisogna avere una certa predisposizione caratteriale per essere in grado di accogliere questi feedback. Poi i feedback possono essere di natura diversa, certe critiche magari non risuonano, però bisogna saperle accogliere e lavorarci con intelligenza. Un problema è che spesso siamo troppo difensivi e ogni critica viene presa come un attacco, invece non funziona così. Queste opere hanno bisogno di maturare, è difficile scrivere una sceneggiatura, soprattutto se ha a che fare con qualcosa di molto personale, come è spesso per le opere prime. C’è una distanza da raggiungere, c’è un distacco da stabilire, ma anche mantenere una visione che viene da dentro, insomma c’è un lavoro psicologico enorme da fare e bisogna essere persone adulte. Se questo processo si riesce a vivere con serenità può diventare molto interessante. Perché è un modo di porsi domande. Anche il fatto di fare dei pitch… uno può dire: “No io non parlo in pubblico, non ce la faccio.” Ma il pitch è molto più di quello, perché se tu ti prepari bene a raccontare la tua storia, poi nel momento in cui la racconti ti rendi conto se qualcosa non si capisce o non funziona. È un lavoro costante di sviluppo e di indagine su quello che stai facendo, che ha un immenso valore. È un processo faticoso, ma anche molto gratificante. Poi non si è da soli, ci sono persone da tutto il mondo.
Come è strutturato il lavoro di sviluppo e dove si svolge?
Il Torino Film Lab ha vari programmi, articolati in tre workshosp e alla fine ci si ritrova qui a Torino dove c’è proprio il pitch market con i produttori. Questo appuntamento finale è quello più grosso, con più persone. Gli altri workshop sono più intimi, ci si ritrova in 20 persone più i tutor in posti ogni anno diversi in giro per l’Europa. Spesso andiamo in Francia in un posto isolato, dove c’è tutto il tempo di immergersi nelle storie, c’è una dimensione molto raccolta. Poi qui a Torino negli stessi giorni del festival, c’è questo momento proprio di mercato: come il contadino che ha cresciuto da solo la verdura nel proprio orto e poi la porta al mercato. E l’incontro con i produttori è di nuovo un’altra forma di relazione. Molti trovano i co-produttori qui. Fare film in fondo è anche costruirsi una squadra, un insieme di relazioni, persone che credono in te e ti supportano e che però siano anche in grado di dirti: “Questa cosa non va bene.” Per molti questa è anche un’esperienza di vita, si cresce molto. Questo approccio poi uno lo trasporta anche nel suo prossimo lavoro. È un processo che non riguarda solo l’opera prima o seconda. È un interrogarsi costantemente sul perché si scrive, su cosa si vuole veramente dire e su come si vuole dire.
Il lavoro di sviluppo ancora appare come una fase confusa e misteriosa nell’industria italiana, non c’è una metodologia e un percorso strutturato diffuso. Possiamo dire che voi siete stati fra i primi ad accendere il faro sulla necessità di investire nello sviluppo progetti?
Si e lo abbiamo fatto con l’idea che un’opera di creazione ha bisogno di un tempo per crescere e maturare e che questo si può fare ascoltando diversi feedback. Non dico che tutti lo debbano fare. Io non credo che sia l’unico modo di lavorare, ma lo sviluppo fatto in questo modo ha aiutato molte persone. Poi certo ci sono quelli capaci di fare da soli il capolavoro, ma non hanno certo bisogno di noi. Noi ci siamo per tutti gli altri che hanno bisogno di un sistema e di uno scambio, in ogni caso credo che pensare a un pubblico, per quanto di nicchia, pensare veramente a cosa sto facendo, anche ormai che siamo sempre più sul micro-budget e i film costano sempre meno… C’è sempre una responsabilità, fare un film costa. Interrogarsi su che cosa voglio fare e non semplicemente rispondere a una propria ambizione, per me ha un valore. Soprattutto in un’arte collettiva come il cinema. Bisogna interrogarsi sul pubblico, anche di nicchia, ma sapere a chi sto parlando. Questo spesso suscita paura: “Allora devo compromettere la mia arte?” Ma no, bisogna fare una cosa e sapere cosa si sta facendo, non esiste opera d’arte senza il rapporto con il suo pubblico, tanto vale prenderlo in considerazione sin da subito. Si crede che l’artista fa quello che vuole quando vuole, sì, ma ponendosi tutta una serie di domande e facendo un sacco di fatica.

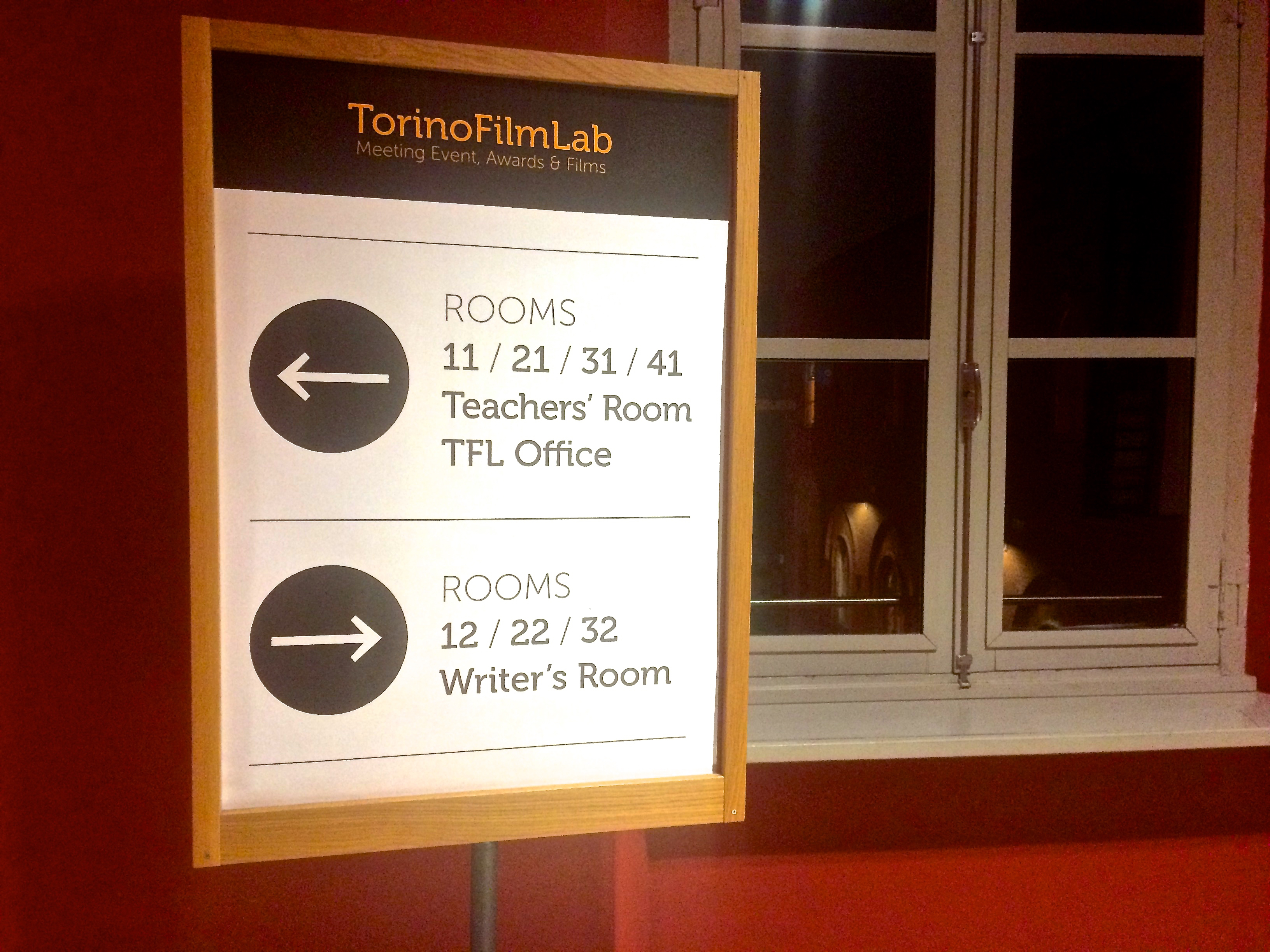
Trovo interessante che facciate anche formazione per gli story-editor, possiamo parlare un po’ di questo mestiere? Già in letteratura l’editor è una figura che il pubblico conosce poco…
Se ne parla nel film Genius, su Max Perkins, uno dei più grandi editor della letteratura americana.
Nel nostro ambiente ho sentito dire che l’editor è uno sceneggiatore fallito…
Assolutamente no. Sono due mestieri diversi. Un conto è riuscire a guardare una serie di opere diverse, di persone diverse, e bisogna sia entrare in empatia, quindi capire quello che lo sceneggiatore vuole dire, sia avere una distanza per vedere se veramente quello che c’è sulla pagina corrisponde alle intenzioni dell’autore e le rappresenta al meglio. E bisogna saperlo fare con idee diverse e di altre persone. Uno story editor deve avere un’ampia conoscenza della narrazione, da tanti punti di vista, di solito sono persone molto colte, che leggono e vedono un mucchio di cose. Ma attenzione non sono i critici, nel senso che non sono lì per mettere a confronto opere da tempi diversi, sono lì per cercare di entrare nelle profondità delle intenzioni dell’opera, più che dell’autore a volte e per aiutare. In fondo sono lì per aiutare. È molto dispregiativo definire l’editor sceneggiatore fallito ed è banale, perché sono persone che hanno un gusto incredibile. In ambito artistico la cosa che gli assomiglia di più è la figura del curatore nell’arte. Qualcuno che abbia la capacità di selezionare, accompagnare e capire a fondo, ma anche di avere uno sguardo leggermente fuori, eccentrico. Lo story editor è un accompagnamento, la spalla, la persona con cui ti confronti ed evita degli attorcigliamenti o delle derive. È un modo di lavorare, anche in questo caso, non dico che sia l’unico.
E i produttori come lo vedono lo story editor?
Dovrebbe vederlo come un grosso alleato, il produttore potrebbe esserlo lui stesso, ormai ci sono dei creative producer al mondo che hanno grandi capacità da story editor e basano tutto su quello, poi si fanno affiancare da persone con capacità più tecniche sui finanziamenti e l’amministrazione. In Italia non è ancora così… Però ci sono dei produttori che si interessano moltissimo di sviluppo, lavorano al fianco degli autori e fanno un lavoro di story editing continuo, anche solo nel rapporto che hanno con gli autori che scelgono, senza magari chiamarlo così. Tutti i nostri story editor lavorano, vuol dire che c’è qualche produttore che li chiama.
Anche in Italia?
Anche in Italia incominciano a lavorare. Qualcosa incomincia… Io poi non riesco a seguire approfonditamente la situazione italiana, perché devo fare un lavoro aperto a tutto il mondo. Poi i produttori italiani che vengono qui sono quelli che amano lavorare come noi.
C’è un aneddoto particolare o un ricordo del Torino Film Lab che ci vuoi regalare?
Ce ne sono tanti… più che uno direi che la cosa personale, che ha reso questa esperienza straordinaria fin dall’inizio, è che è stata segnata da una serie di incontri importantissimi. Io da sola non sarei mai riuscita a farlo, senza attrarre continuamente da tutto il mondo persone che hanno colto il valore di questo progetto, lo hanno sposato e ci hanno messo la loro energia. A tutti i livelli, a partire dallo staff: il nostro staff è molto internazionale, alcuni lavorano qui a Torino ma altri no. Il direttore artistico, Matthieu Darras, è francese e vive a Bratislava, la managing director, Mercedes Fernandez Alonso, è spagnola e vive a Torino, la project manager, Agata Czerner, è polacca. C’è questa qualità umana… Anche i tutor li ho incontrati così: io giravo per i festival, parlavo e sentivo che c’era una sintonia. I tutor sono quelli che guidano i gruppi e sono story editor professionisti, che non sono necessariamente sceneggiatori, anzi. Io mi ricordo come ho incontrato ciascuna di queste persone. E andata così: ho avuto un’idea e pian piano l’ho vista crescere e prendere forma grazie alle persone che ho coinvolto. La squadra è stata internazionale da subito; io sono partita con una svedese, un tedesco, anche un italiano. E sono stati incontri semi-accidentali, ma basati su un modo di lavorare, un’energia e una passione che avevamo in comune. Questo è un po’ il miracolo che ci ha portato a questi risultati.
Quale è stato il tuo percorso formativo e professionale?
Io sono laureata in filosofia e subito dopo la laurea sono stata fra i fondatori della scuola Holden, sono nata nel mondo della formazione. All’inizio la Holden era una scuola per trenta persone, poi è diventata quella dove siamo ora. La Holden è una scuola di scrittura, ma soprattutto è una scuola di story-telling. Dopo un po’, prima del Torino Film Lab, feci una richiesta alla Comunità Europea per un programma che si chiamava Script & Pitch, che è ancora il nome di uno dei nostri percorsi, che doveva essere un programma isolato, ma già pensato come ponte dalla scuola Holden verso il resto del mondo. Poi c’è stato l’incontro con Alberto Barbera, che ha trovato interessantissimo quello che stavamo facendo e che mi ha permesso lo sviluppo verso il Torino Film Lab. Vedendo Script & Pitch lui si è chiesto cosa potevamo fare di ancora più grosso. E da lì è nato il Torino Film Lab.
Cosa ci aspetta nel futuro del Torino Film Lab?
Noi finora ci siamo occupati solo di cinema, fiction, ma anche documentario, inteso come documentario di creazione e narrazione, dall’anno prossimo ci occuperemo anche di serialità per la televisione. Abbiamo lanciato la call internazionale per serie televisive a settembre, è stata aperta per quattro settimane e abbiamo ricevuto cento progetti da tutto il mondo, che stiamo selezionando adesso. Quindi l’anno prossimo ci sarà anche il Series Lab. Noi abbiamo ereditato quel progetto della film-commission Torino Piemonte che era il Fiction Lab, che adesso è diventato internazionale. I nove progetti selezionati e sviluppati faranno un pitch al festival Series Mania a Parigi.
Grazie Savina, sentendo le tue parole veramente viene voglia di partecipare a questo lavoro di sviluppo con questa atmosfera stimolante e internazionale. WGI ha tra i suoi soci molti autori di serialità. Ho solo una domanda tecnica i lavori si svolgono tutti in lingua inglese, ma è necessario anche scrivere bene in inglese?
Bisogna saper parlare e capire perché è fondamentale per lo scambio con gli altri, poi sulla scrittura ognuno può anche lavorare nella propria lingua e poi tradurre. L’inglese serve più per comunicare.
Tutte le informazioni sul Torino Film Lab le trovate sul sito web.
In otto anni il Torino Film Lab ha aiutato ben 68 film, di cui 14 sono presenti quest’anno al Torino Film Festival, distribuiti tra l’apposita sezione Film Lab e Festa Mobile. Abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione, nella quale abbiamo trovato molto interessanti gli interventi di Paloma Aguilera, sceneggiatrice e regista di Out of Love (Olanda/Francia); Raymond Phathanavirangoon, produttore di Apprentice (Singapore/ Ger/ Fra/ HK/Qatar); Axel Koenzen, sceneggiatore e regista di Dead Weight (Germania/ Finlanda); Pablo Lamar, sceneggiatore e regista di La Ultima Tierra (Paraguay/ Olanda/ Cile/ Qatar).
Avete tutti preso parte a programmi, anche in anni diversi, del Torino Film Lab. Realizzare un film è un processo faticoso e lungo, nella vostra esperienza quale è stata la parte più difficile del lavoro?
Paloma Aguilera: Per me l’inizio, perché si è abituati a scrivere da soli, ed è stata la prima volta che ho dovuto condividere il mio lavoro con altri. È stato complicato, è una cosa che può fare paura e poi nel mio gruppo c’erano delle persone toste, con un carattere forte. È stato difficile iniziare, ma dopo è stato fantastico poter condividere, lavorare insieme sulle storie. Questa condivisione già in fase di sceneggiatura aiuta a essere più universali nel proprio messaggio, perché si lavora insieme ad altri. E anche la parte finale è stata difficile, i pitch, il mio pitch è stato un disastro, ma comunque è stato molto interessante e utile anche quello.


Axel Koenzen: Per me la cosa più difficile è stata gestire l’ambivalenza tra il processo di ricerca e scrittura e il fare i pitch, perché devi riuscire a vendere la tua storia mentre la stai ancora cercando. Bisogna accettare una certa vulnerabilità nel lavoro con gli altri, nel riscrivere la propria storia seguendo i feedback del gruppo. E poi invece la fase finale dei pitch serve proprio a vendere l’idea e l’atteggiamento che uno deve avere è abbastanza diverso. Il pitch per un autore è un banco di prova, un modo di testare la propria idea e come la si è sviluppata di fronte a un pubblico. È meglio pensarlo in questo modo, piuttosto che come l’esibizione di un pacchetto finito, pronto per essere venduto. Un film è sempre un processo lungo, soprattutto se è un primo film, è qualcosa in divenire, che si evolve costantemente; quindi quando il pitch è solo un presupposto che deve essere completato, è un’idea che deve essere testata per ulteriori sviluppi.
È per questo che anche il pitch, attraverso il confronto con gli altri e la collaborazione, ti permette di migliorare le tue capacità di narratore, le tue tecniche. Bisogna pensare ai pitch non solo come presentazione del progetto, ma anche come tappa per capire a che punto si è del lavoro, per vedere gli elementi che al momento ci sono, ma che possono anche cambiare. Per questo è importante che anche dall’altra parte non ci siano solo dei compratori che vogliono il pacchetto finito, ma persone che sappiano prendere in considerazione le idee come qualcosa che deve essere ulteriormente sviluppato.
Pablo Lamar: Per me ci sono stati due momenti di difficoltà: il primo è stato quello relativo alla parte finanziaria e al reperimento dei fondi per il film. Venendo dal Paraguay è stato molto difficile trovare nel mio paese fondi sufficienti alla realizzazione di un film. Queste difficoltà erano correlate al processo di scrittura, perché la sceneggiatura è fondamentale nel reperimento dei fondi, come anche qui al Lab si lavora da subito sulla sceneggiatura. Per me è stata una fase lunga di cinque o sei anni, e in alcuni momenti è stato faticoso e si perde la fiducia in se stessi e nel progetto. Poi l’altra difficoltà riguarda sempre la sceneggiatura, nel senso però di rimanere fedeli all’idea e allo spirito con cui si è partiti per voler fare un film. Prima del Torino Film Lab il mio film era scritto in 13 pagine, perché ci sono pochissimi dialoghi, anzi quasi zero, il film è tutto basato sui suoni e sulle immagini; queste 13 pagine sono riuscito a espanderle a 37 pagine, che comunque è un buon numero considerando che non ci sono battute di dialogo, ma soprattutto ero rimasto fedele alla visione originaria, senza togliere l’anima al film. Poi come diceva Axel la parte di lavoro dei pitch è stata importante, perché si impara tanto sul proprio ambito di lavoro, mi riferisco alla scrittura, ma anche di altre parti del lavoro che serve per fare un film, dal punto di vista della fotografia, della produzione, eccetera.

Raymond Phathanavirangoon: Per me è un po’ diverso perché sono il produttore non l’autore o il regista, il nostro progetto ha partecipato nella sezione di audience design del Torino Film Lab, quindi è stato un po’ diverso il percorso che per gli altri. Per me in realtà la parte dei pitch non è stata difficile, anzi è stata quella più divertente, sono stato molto soddisfatto dei feedback. Mi è piaciuto molto, il mio regista è più silenzioso di me, mentre io parlo molto… Il film è una co-produzione fra cinque paesi: Singapore, Germania, Francia, Hong Kong, Qatar. È stato molto complicato, era difficile vendere un progetto che aveva come protagonista un boia, una persona che di lavoro esegue le sentenze capitali. Andare in giro e dire: “Salve il nostro film parla di uno che impicca la gente.” Non era esattamente il pitch più facile del mondo…

Soprattutto a Singapore, dove esiste ancora la pena di morte, molte persone non volevano sentir parlare dell’argomento. Inizialmente non ci hanno dato i finanziamenti e non ci hanno concesso di girare nelle carceri, anche perché le carceri erano sovraffollate. Abbiamo provato a chiedere di girare in Malesia, ma ci hanno detto di no, alla fine abbiamo girato in Australia, dove invece ci sono molte carceri dismesse e vuote. Quindi per via del tema sensibile il film ha avuto un po’ di difficoltà, abbiamo cambiato molte location, poi siamo riusciti a convincere Singapore a sostenerci economicamente. Alla fine ce l’abbiamo fatta, ci sono voluti solo 2 anni, ma domani finalmente il film esce in Malesia, dove sono molto contenti che non sia stato girato da loro.
Cosa rappresenta per un regista il Torino Film Lab? È un punto di partenza, di passaggio o una conquista, un punto di arrivo?
Paloma Aguilera: Per me il discorso importante, che in parte è stato già fatto, è che un film è un processo continuo, in continua evoluzione e trasformazione. Quindi il Lab è sicuramente un punto di passaggio, perché c’è sempre qualcosa che viene dopo, non un punto di arrivo.
Raymond Phathanavirangoon: Io oltre che produttore sono anche co-sceneggiatore e quindi sono nel progetto sin dall’inizio. Il lavoro al Torino Film Lab ci ha aiutati enormemente a superare dei blocchi che avevamo nel raccontare la storia. La parte più importante è stata proprio quella dei feedback, che ci hanno aiutati ad avere un altro punto di vista sulla sceneggiatura. A volte è necessario pensare fuori dagli schemi e per questo il Lab ci ha aiutati molto.




